Dello scorso 10 luglio è la decisione del Premier turco Recep Tayyip Erdoğan di riconvertire, dopo quasi un secolo, la basilica di Santa Sofia, sconsacrata per divenire un museo nel lontano 1 febbraio 1935 dall’allora leader nazionalista laico Mustafa Kemal Atatürk. Si tratta di un evento importante, curioso, che si configura chiaramente come un messaggio non tanto verso l’interno politico, sociale e cultura turco (per quanto in parte sì), bensì all’esterno, ad un contesto internazionale che sta cercando ancora una definizione, un assestamento. Ma come decifrare questo messaggio? A chi può essere rivolto? Cosa intende comunicare? Con questo pezzo vorrei cercare di rispondere a queste domande e delineare una sorta di retrospettiva, suscitando auspicabilmente qualche riflessione.
A gettare un poco di luce sulla questione ci aiutano le illuminanti considerazione che Fabio Scacciavillani ci ha sottoposto nella puntata del 15 luglio del podcast Daily Cogito di Rick DuFer (qui il link alla puntata completa https://youtu.be/qlk4jQLMbwU). Lo Scacciavillani collega alla decisione di Erdoğan tre elementi principalmente:
1. La riconversione a moschea si configura come una reazione alla scelta del Presidente USA Donald Trump di porre l’ambasciata statunitense presso Israele a Gerusalemme, giustificando di fatto la collocazione politica della città sotto il dominio israeliano. Non è un problema da poco, né per gli equilibri internazionali (poiché la Turchia è politicamente filopalestinese), né per il versante religioso, poiché a Gerusalemme si trova una delle moschee più importanti dell’intero Islam: la Moschea al-Aqşā. La “Moschea Estrema” è divenuta un simbolo fondamentale delle pretese musulmane sulla città, in opposizione alle pretese israeliane di matrice giudaica. Appropriarsi di Santa Sofia significa appropriarsi di Istanbul, definire un’identità della città che prima poteva apparire molto più aperta e cosmopolita, turca nominalmente ma con l’occhio a guardare verso l’Occidente;
2. Questa decisione si iscrive nello scivolamento di tanti Paesi di confessione islamica nel fondamentalismo, da leggersi alla luce di un ritorno all’unicità e al particulare mediorientale e terzomondista in opposizione alle ingerenze occidentali, che vengono indirettamente da Europa e Stati Uniti e direttamente da Israele, e che ha caratterizzato nella storia degli ultimi 40 anni rivoluzioni politiche come quelle di Tunisia, Egitto, Algeria, Iran e la stessa Turchia negli ultimi anni;
3. In diretto collegamento con il punto precedente, Erdoğan prende questa decisione in quanto figlio di una cultura che ha visto la moschea come principale luogo di dibattito e propaganda politica. Questo aspetto lascia intendere che il Premier turco abbia voluto prendere con questa mossa due piccioni con una fava, poiché sottintende l’iscrizione della Turchia ad una certa linea, che possiamo definire qui per comodità neoterzomondista (poiché si tratterebbe di un ripensamento dei presupposti del terzomondismo che hanno animato i decenni centrali del Novecento in Medio Oriente) per quel che riguarda la politica estera, e di una appropriazione di un fondamentale spazio politico in politica interna.
Ora, il primo punto, soprattutto per coloro che si tengono informati sulle notizie del mondo e che abbiano un minimo di conoscenza della storia anche solo novecentesca, sembra pacifico da afferrare e condividere. La questione di Gerusalemme è sempre stata il centro di una guerra sanguinosissima e di tensioni internazionali le cui dimensioni vanno ben oltre i soli confini di Israele e Palestina. Per sintetizzare (e anche un po’ semplificare, mi scusino i più esperti sulla questione), Israele è per la sensibilità mediorientale una vera e propria “breccia” che l’Occidente ha sfondato arbitrariamente nel cuore di un territorio che, al netto di enormi e numerosissime differenze culturali, etniche e religiose presenti soltanto in quella specifica area geografica (per intenderci, Siria, Palestina, Giordania, fino ad arrivare a Gaza), era comunque concepito come territorio unito nella umma (“comunità” in arabo, la cui radice umm vuol dire letteralmente “mamma”, per dare un po’ il senso di come venga vissuta la questione da chi è di fede musulmana) che è l’Islam. Israele, in questo contesto, appare come un’isola culturale, politica e religiosa in un mare che è completamente alieno, e in questo contesto la città di Gerusalemme è letteralmente spaccata, smembrata e contesa da questi due macromondi (Occidente da una parte e Islam dall’altra). La decisione di Trump, dunque, di porre l’ambasciata USA per lo Stato di Israele a Gerusalemme non solo cancella con una firma decenni di mediazione diplomatica tra due fazioni in guerra, ma si configura come una appropriazione totale di una città fondamentale per almeno tre confessioni religiose completamente diverse, che coesistono e disputano da decenni tra loro per la rivendicazione dei patrimoni (soltanto a Gerusalemme Est vi sono la sopra citata Moschea al-Aqşā, il Santo Sepolcro e il Tempio di Salomone). La scelta del Premier turco, dunque, sembra iscriversi proprio su questa linea di appropriazione nazionalista che si gioca tutta sul possesso dei luoghi di culto, come a dire «Israele ha al-Aqşā, noi abbiamo Santa Sofia», con una rivendicazione religiosa più che strumentale agli occhi della comunità internazionale.
I punti 2 e 3, invece, richiedono importanti approfondimenti. Come giustamente spiega lo stesso Fabio Scacciavillani, l’autoritarismo di Erdoğan con questa decisione sembra ulteriormente inasprirsi, fin quasi a ripiegarsi su se stesso in una contraddizione che soltanto il futuro potrà sciogliere o meno: dalla fine degli anni ‘60, infatti, nei Paesi musulmani del Medio Oriente la moschea aveva assunto un ruolo fondamentale come luogo nel quale poter fare propaganda antiregime, contro l’autoritarismo di governi soltanto all’apparenza liberali e che tendevano, in altri luoghi diversi dalle moschee, a reprimere anche violentemente le pubbliche manifestazioni di dissenso politico. Poiché nessun Governo, neanche il più tirannico e repressivo, avrebbe osato attaccare una moschea e ledere il corpo e l’autorità di personalità religiose come gli imam per i sunniti e gli ayatollah per gli sciiti (si ricordi che Khomeini, leader della rivoluzione iraniana, era appunto un ayatollah), all’interno delle moschee si radunavano i più disparati gruppi di dissidenti. È bene ricordare che lo stesso Erdoğan, in gioventù, fece parte di questi movimenti in Turchia e seguiva con passione il suo mentore, Necmettin Erbakan, il quale predicava un ripudio dei valori laici e un allontanamento dall’Occidente della Turchia a favore del ritorno ad un Islam vissuto in modo puro e integralista come lo era prima di Kemal Atatürk.
È evidente dunque dove porta questa ricostruzione: se il luogo di coagulazione e consolidamento del dissenso politico era la moschea, e se imam e ayatollah, oltre al ruolo di guide e punti di riferimento religiosi divenivano anche leader politici, la direzione della radicalizzazione dei dissidenti non poteva che essere religiosa. Questo spiegherebbe la forte recrudescenza fondamentalista che anima l’operare politico del Premier turco, anche se è proprio qui che emerge la contraddizione: rendere Santa Sofia una moschea dopo che era stata per quasi un secolo un museo, neutro e imparziale nel suo essere per tutti in quanto patrimonio dell’umanità, non è forse, oltre la semplice appropriazione del luogo di culto, anche la legittimazione di un luogo di dissenso politico che potrebbe minare la sua leadership, come fossero due facce della stessa medaglia? Non può essere un caso che questa scelta piaccia sia ai sostenitori del Governo sia all’opposizione, come se fossero tutti animati dallo stesso spirito di rivendicazione nazionale di un luogo sacro per il popolo turco. Questa scelta, insomma, dal suo apparire molto radicale in realtà in profondità sembra essere un po’ cerchiobottista, soprattutto dopo le forti critiche, all’interno e all’estero, che il leader ha ricevuto per le violente azioni repressive verso i dissidenti o i presunti tali. Una sorta di contentino, insomma, per calmare un’opposizione sul piede di guerra e una popolazione fortemente provata da una importante crisi economica e dalle ultime azioni militari condotte dal leader.
Per concludere, osservare Erdoğan in questi ultimi anni è complicato e il suo agire si presta a diverse letture, tutte più che plausibili: si può vedere del nervosismo nel suo agire ma anche una razionale pianificazione; un desiderio di integrazione internazionale, entrando magari anche all’interno dell’Unione Europea, ma anche una volontà di rottura e di allineamento differente del Paese nello scacchiere geopolitico globale. In effetti, è nostro alleato militare dal momento che fa parte della NATO, anche con un cospicuo contingente di unità, ma nel contempo ci ricatta con minacce di scatenare orde di migranti e profughi che si riverserebbero in Europa; sostiene Assad in Siria e Putin nei suoi tentativi di ritagliarsi la sua area di influenza in Medio Oriente. Quel che mi pare di vedere, però, in questo comportamento apparentemente schizofrenico non è tanto la ricerca di un allineamento da abbracciare, quanto il desiderio di creare un proprio allineamento e vedere chi è disposto ad abbracciarlo, in un pomposo ideale di grandeur turca dal retrogusto ottomano, portata avanti con uno spregiudicato opportunismo, e utile solo a galvanizzare un Paese che economicamente è in seria difficoltà e socialmente è sempre più vittima di clientelismi e di dinamiche di potere poco trasparenti.
Laureato in filosofia e storia, specializzato in filosofia antica e appassionato anche di cose serie come politica, cinema e videogiochi. Adoro stare in compagnia, amo la buona cucina e, nel mentre, cerco di essere più informato e consapevole possibile.








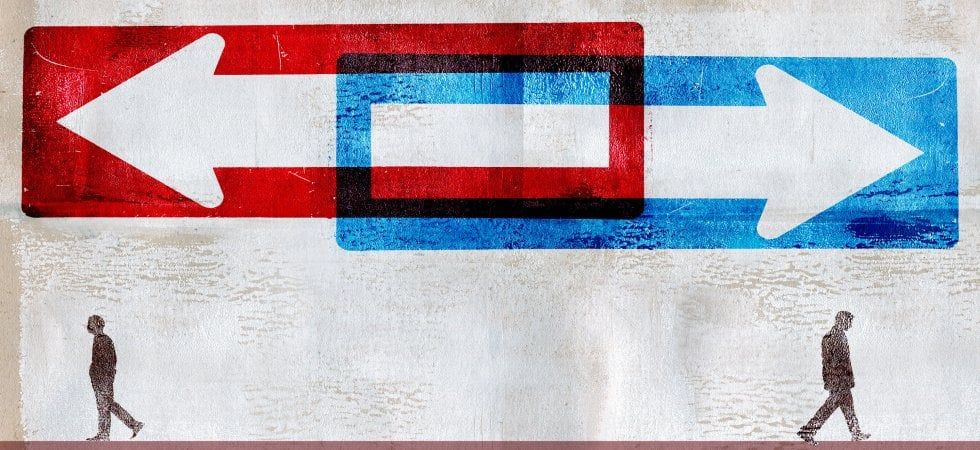







No Comments
Leave a comment Cancel